In autunno le valli acquistano toni differenti: i boschi si tingono di colori caldi e ramati, i sentieri profumano di umidità e funghi, e la luce del sole disegna nuove ombre sulle pietre e nei prati. Per apprezzare appieno questi cambiamenti del paesaggio non solo a piedi ma anche in bicicletta è possibile percorre un percorso speciale: il Sentiero della Pietra e del Marrone.
Si tratta di un itinerario escursionistico e ciclabile, adatto per bici MTB e gravel, che si sviluppa a mezzacosta lungo il versante orografico destro della Bassa Valle di Susa e attraversa castagneti secolari, borgate montane e antiche cave di pietra. Percorrerlo significa compiere un piccolo viaggio nella storia rurale e artigiana della bassa valle, un racconto inciso nella roccia e nei tronchi nodosi dei castagni.

Il Sentiero della Pietra e del Marrone: l’itinerario
La partenza ideale per compiere questo itinerario è Susa, da dove si imbocca la celebre salita al Colle delle Finestre. Ne si percorre solo il primo tratto fino a Meana, dove si raggiunge borgata Assiere: qui si abbandona l’asfalto in favore di un sentiero immerso in boschi di castagno. Si pedala in direzione di Mattie, fino a incontrare i primi sterrati nei presso di borgata Menolzio, dove sorgono la torre e i resti di una casaforte medievale del XII secolo.
Superate le borgate di Mattie, si entra nel vivo dell’itinerario, che alterna sterrati e tratti di single track. Il fondo è vario, con brevi tratti più tecnici dove, con bici gravel, può essere necessario scendere e proseguire a piedi. Siamo nel cuore del percorso, dove i castagneti sono i veri protagonisti. Questi alberi sono parte integrante dell’identità di questo territorio: hanno nutrito intere generazioni, modellato l’economia locale e continuano a scandire il calendario con la raccolta annuale dei marroni e con feste e sagre che celebrano questo frutto.
A Bussoleno i percorso si apre verso le borgate dell’inverso, raggiungibili con una piccola deviazione dal percorso principale: Tignai, Meitre e Bessetti. Qui la pietra non è solo materia da costruzione, è memoria viva: si intravedono infatti alcune vecchie cave, dove le rocce, segnate dal lavoro di estrazione, si mostrano oggi come sculture naturali fatte di geometrie inattese e bellezza ruvida.
Proseguendo, si scorge dall’alto Castel Borello. Oggi privato, l’edificio sorge su uno sperone roccioso ed era parte di un sistema difensivo che includeva il vicino Castello di San Giorio, entrambi a controllo dell’antica Strada di Francia che attraversava il fondovalle.
Si raggiungono poi le borgate Pognant, Martinetti e Viglietti a San Giorio, sempre pedalando in splendidi boschi di castagni, per poi percorrere la parte finale del percorso fino a Villar Focchiardo e a borgata Banda. Oggi abitata da pochi privati, questa borgata conserva ancora i resti di una Certosa costruita dai monaci certosini nel Quattrocento dopo l’abbandono del più isolato monastero di Montebenedetto a causa delle continue alluvioni.
Da Banda una ripida discesa conduce al paese di Villar Focchiardo, completando così l’itinerario. I più allenati possono affrontare un’ultima e impegnativa salita che porta alla Certosa di Montebenedetto, percorrendo circa 8 km con pendenze intorno al 9%, per arrivare a quota 1.200 metri e ammirare il complesso monastico. La Certosa, luogo di pace e silenzio, è stata restaurata nei primi anni 2000 e troviamo una chiesa romanica a una sola navata, un alpeggio, una piccola foresteria e un affresco quattrocentesco della Madonna con Bambino sopra l’antico ingresso.
Per tornare a Susa, si può scegliere tra più alternative. La più diretta è percorrere la Ciclovia Francigena, oppure seguire la viabilità secondaria passando per Borgone di Susa, San Didero, Bruzolo, Chianocco e Bussoleno, pedalando tra coltivi, frazioni e piccoli centri. Questo tratto, meno impegnativo dal punto di vista tecnico, permette di osservare da un’altra prospettiva il versante opposto appena attraversato, chiudendo idealmente il cerchio.

Un paesaggio da attraversare e custodire
Il Sentiero del Marrone e della Pietra ci svela le due anime produttive di questa porzione di territorio: la coltivazione del castagneto da frutto e l’estrazione della pietra.
La castanicoltura in Val di Susa fu probabilmente introdotta in epoca romana, ma si consolidò nel Medioevo, quando i castagni divennero una risorsa insostituibile. Fino alla metà del Novecento, i marroni erano fonte di reddito e sostentamento: venivano conservati, scambiati, venduti, persino esportati. Poi arrivarono l’abbandono della montagna, le malattie del castagno e il cambiamento dei consumi alimentari, che segnarono il declino di questa coltura.
Negli ultimi decenni, grazie alla tenacia di alcuni produttori e alla certificazione IGP, i marroni della Val di Susa stanno vivendo una seconda giovinezza. Ma le sfide sono ancora molte: dal Cinipide galligeno che indebolisce gli alberi, al cambiamento climatico e agli sbalzi termici sempre più violenti, fino all’impossibilità di meccanizzare la raccolta a causa delle pendenze dei terreni.
La pietra, l’altra anima del Sentiero, non solo ha plasmato l’architettura locale, ma è stata anche fondamenta e volto di chiese, ponti e palazzi torinesi in epoca sabauda. Per secoli, tra queste borgate, si è estratto gneiss, una roccia dura e resistente detta anche “granito della Val di Susa“. Le cave – oggi in maggioranza chiuse – si distinguono ancora tra le “macchie” grigie che interrompono il verde dei boschi.
A estrarre e modellare la roccia erano i picapera, gli scalpellini. Non semplici manovali, ma veri e propri artigiani capaci di leggere le venature della pietra. Sapevano dove colpire per aprire la roccia senza spezzarla, seguendo le sue linee naturali con rispetto. Il loro sapere non era scritto, ma trasmesso a voce, da generazione a generazione.
Prestando attenzione ai segni disseminati lungo tutto l’itinerario, scopriamo che il Sentiero del Marrone e della Pietra è una narrazione che collega paesaggi, comunità, saperi. È un’occasione per ripensare il turismo outdoor non come consumo rapido di luoghi, ma come relazione attiva con l’ambiente, la storia e le persone. Percorrerlo in bici o a piedi significa infatti attraversare una porzione di territorio fatta di dettagli da cogliere: il muro a secco ben fatto, il sentiero curato, il castagno potato. Significa riconoscere che i territori montani hanno bisogno di manutenzione, lavoro, rispetto e attenzione, ma anche che possono offrire esperienze ricche, coinvolgenti e sostenibili.







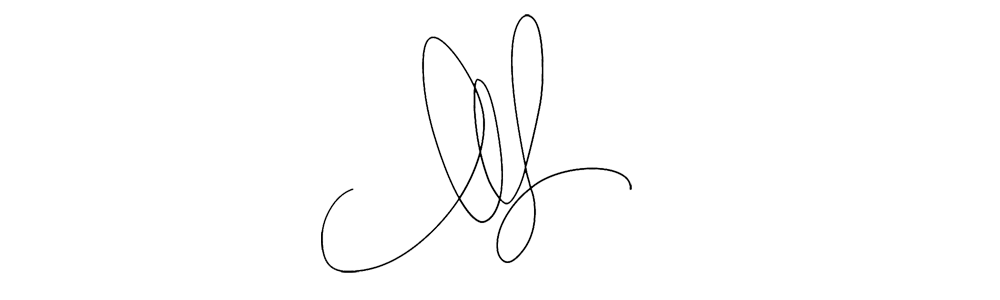




Leave A Reply